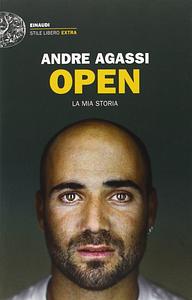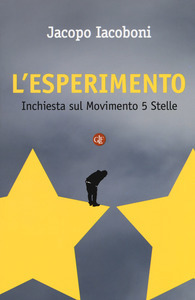You need to sign in or sign up before continuing.
Take a photo of a barcode or cover
diffrazioni's reviews
397 reviews
Tantissimo tennis, naturalmente, forse un po' troppo per chi non ne è appassionato. Ma anche una storia di alti e bassi, fanatismi, genitori privi di senno, amori e ideali. Un bel libro, davvero.
Un libro che dovrebbe leggere, prima di tutto, chi il M5S ha votato. Ma anche tutti gli altri, per avere una migliore comprensione di come funzioni, quello che oggi è la prima forza politica d'Italia (meglio non dire partito, perché i partiti sono una cosa diversa).
La prima cosa che salta fuori con chiarezza è questa: il M5S è saldamente nelle mani di un'azienda. La Casaleggio, ovviamente, che governa sin dall'inizio questo inedito 'esperimento' politico e sociale. Un'azienda con qualche buco: il suo patrimonio principale è la gestione dei dati, che però, nei server della Casaleggio sono tutt'altro che al sicuro. Più di una volta degli hacker sono riusciti a mettere mano ai preziosi dati posseduti dalla Casaleggio.
Seconda cosa che ne ho ricavato dalla lettura di questo libro: la conferma che il M5S non è né di destra né di sinistra. Si adatta al contesto, si adatta a quanto occorre per ottenere il consenso. Questo, se è vero e se l'ho capito bene, mi spiega come sia possibile che Chiara Appendino e Virginia Raggi siano così diverse tra loro. La prima può andare bene a Torino, ma non a Roma e viceversa.
Può darsi che questo influenzi anche la politica estera. Il M5S - questo l'avevo già capito da solo - non ha una linea, in politica estera. Il M5S passa dall'esaltazione di Anna Politkovskaja a quella di Vladimir Putin, senza battere ciglio. Così come, senza battere ciglio, cerca alleanze con Verohfstadt e con Farange, quasi in contemporanea.
Devo dire, però, che ciò non mi pare distingua il M5S dalle altre forze politiche, che dubito abbiano una linea salda e chiara. Basta pensare a Renzi che riesce contemporaneamente a dirsi a favore dei diritti umani e amico di chi dei diritti ne fa carta straccia, come il presidente dell'Egitto o, ancora, a tutte le forze politiche che chiedono il rispetto delle risoluzioni internazionali tranne quanto queste riguardano paesi alleati.
Il libro racconta ancora diversi casi in cui è netta la differenza tra il dichiarato e il praticato: è il caso dei rimborsi. Di Maio non restituisce metà dello stipendio e neppure i rimborsi oltre alla quota inizialmente dichiarata (2.500 euro al mese). Non fanno nulla di male, sia chiaro, solo non rispettano gli impegni che si sono assunti.
Un esperimento, insomma. Vediamo come andrà a finire.
La prima cosa che salta fuori con chiarezza è questa: il M5S è saldamente nelle mani di un'azienda. La Casaleggio, ovviamente, che governa sin dall'inizio questo inedito 'esperimento' politico e sociale. Un'azienda con qualche buco: il suo patrimonio principale è la gestione dei dati, che però, nei server della Casaleggio sono tutt'altro che al sicuro. Più di una volta degli hacker sono riusciti a mettere mano ai preziosi dati posseduti dalla Casaleggio.
Seconda cosa che ne ho ricavato dalla lettura di questo libro: la conferma che il M5S non è né di destra né di sinistra. Si adatta al contesto, si adatta a quanto occorre per ottenere il consenso. Questo, se è vero e se l'ho capito bene, mi spiega come sia possibile che Chiara Appendino e Virginia Raggi siano così diverse tra loro. La prima può andare bene a Torino, ma non a Roma e viceversa.
Può darsi che questo influenzi anche la politica estera. Il M5S - questo l'avevo già capito da solo - non ha una linea, in politica estera. Il M5S passa dall'esaltazione di Anna Politkovskaja a quella di Vladimir Putin, senza battere ciglio. Così come, senza battere ciglio, cerca alleanze con Verohfstadt e con Farange, quasi in contemporanea.
Devo dire, però, che ciò non mi pare distingua il M5S dalle altre forze politiche, che dubito abbiano una linea salda e chiara. Basta pensare a Renzi che riesce contemporaneamente a dirsi a favore dei diritti umani e amico di chi dei diritti ne fa carta straccia, come il presidente dell'Egitto o, ancora, a tutte le forze politiche che chiedono il rispetto delle risoluzioni internazionali tranne quanto queste riguardano paesi alleati.
Il libro racconta ancora diversi casi in cui è netta la differenza tra il dichiarato e il praticato: è il caso dei rimborsi. Di Maio non restituisce metà dello stipendio e neppure i rimborsi oltre alla quota inizialmente dichiarata (2.500 euro al mese). Non fanno nulla di male, sia chiaro, solo non rispettano gli impegni che si sono assunti.
Un esperimento, insomma. Vediamo come andrà a finire.
Un paio d'ore di discussione tra due persone curiose. C'è molta fisica, nella chiacchierata tra Levi e Regge, a tratti pure specialistica. Ma ci sono anche riflessioni sul modo con cui ci si pone di fronte ai problemi. Nelle parole dei due torinesi c'è una voglia di capire che sovrasta quella di giudicare. Il dialogo nella sua forma più bella.
Una formula banale, così semplice che la può capire anche chi ha le nozioni matematiche della scuola media (e forse pure delle elementari). Eppure, dimostrare questa formula, è stato il più arduo compito della storia della matematica.
Simon Singh usa la vicenda dell'ultimo Teorema di Fermat per raccontare la storia non solo della matematica, ma più in generale del pensiero umano. Racconta i momenti bui, come quando prima i fanatici cristiani e poi quelli islamici, uccisero la straordinaria esperienza della biblioteca d'Alessandria, contribuendo a far sprofondare le fiorenti società occidentali nel Medio Evo (serva da monito: le conquiste intellettuali e civili non sono mai definitive, si può sempre tornare indietro).
Racconta la difficoltà che le donne hanno avuto nell'ottenere il rispetto dovuto, nel mondo della scienza (un problema che permane ancora oggi: tra i tanti che nel '900 hanno dato l'assalto all'ultimo teorema di Fermat, ma non vi è nessuna donna).
Ma tra le storie tragiche vi è anche l'avventura di una conquista intellettuale che nasce da un dettaglio (una banale formula, appunto, appena più complicata del teorema di Pitagora), per svilupparsi in tanti campi diversi e fondamentali. Un po' di basi matematiche le ho, ma credo che chiunque possa lasciarsi trasportare da Singh in questo racconto straordinario.
Simon Singh usa la vicenda dell'ultimo Teorema di Fermat per raccontare la storia non solo della matematica, ma più in generale del pensiero umano. Racconta i momenti bui, come quando prima i fanatici cristiani e poi quelli islamici, uccisero la straordinaria esperienza della biblioteca d'Alessandria, contribuendo a far sprofondare le fiorenti società occidentali nel Medio Evo (serva da monito: le conquiste intellettuali e civili non sono mai definitive, si può sempre tornare indietro).
Racconta la difficoltà che le donne hanno avuto nell'ottenere il rispetto dovuto, nel mondo della scienza (un problema che permane ancora oggi: tra i tanti che nel '900 hanno dato l'assalto all'ultimo teorema di Fermat, ma non vi è nessuna donna).
Ma tra le storie tragiche vi è anche l'avventura di una conquista intellettuale che nasce da un dettaglio (una banale formula, appunto, appena più complicata del teorema di Pitagora), per svilupparsi in tanti campi diversi e fondamentali. Un po' di basi matematiche le ho, ma credo che chiunque possa lasciarsi trasportare da Singh in questo racconto straordinario.
«Portavo quasi sempre i miei tacchi dodici. Senza dubbio la gente si chiedeva: “Perché una testimone della guerra indossa scarpe del genere?” […] Avevo bisogno di confondere le aspettative delle persone […] Alcuni volevano aiutarmi, e non potevano sopportare l’idea che non mi sentissi sconfitta. Il panico appariva sui loro volti quando suggerivo a quelli che si consideravano più potenti di me che la transazione poteva essere a doppio senso. Che anch’io avrei potuto aiutare loro».
Del genocidio dei Tutsi, nel libro di Clemantine Wamariya c’è poco. Non c'è neanche molto Rwanda, a dire il vero. C'è la storia di come lei e sua sorella Claire hanno girato mezza Africa, tenacemente attaccate al desiderio di vivere. Clemantine inizia il viaggio che ha sei anni, Claire è appena diventata adolescente.
Poi c'è la vita di Clemantine negli Stati Uniti, dove arriva quando tocca a lei, essere adolescente. E qui, dove finalmente non ha più il problema della sopravvivenza, Clemantine cerca di dare un senso alla sua esistenza, non riuscendo a trovarsi a proprio agio in quel ruolo che molti si aspettano lei assuma: quello della sopravvissuta, vittima di guerra che ringrazia la buona sorte e le persone di buon cuore che le hanno permesso di ricominciare tutto da capo. Certo, mostra gratitudine a chi le ha dato tanto, ma questo non le basta per rimettere insieme i pezzi della sua storia.
Emblematico è il racconto che fa di un momento in cui, a un convegno, un relatore racconta di come alcuni profughi che aveva incontrato avessero l'ansia di digitalizzare, così da non perderle, alcune foto che s'erano portate appresso. Al relatore sembra una cosa curiosa, quasi divertente: "non sai se riuscirai a mangiare e pensi alle foto?". Clemantine spiega che quelle foto, spesso, sono l'unica connessione con un passato che ti è stato sottratto in modo brutale.
«La ragazza che sorrideva perline» è uno dei libri più interessanti che abbia letto, intorno alla vicenda del genocidio del 1994. Perché da lì prende spunto per farci entrare nella condizione di persone che, a causa di violenze, sono costrette a vagare, in cerca prima di un modo per sopravvivere e poi di un modo per tenere insieme la propria coscienza.
Del genocidio dei Tutsi, nel libro di Clemantine Wamariya c’è poco. Non c'è neanche molto Rwanda, a dire il vero. C'è la storia di come lei e sua sorella Claire hanno girato mezza Africa, tenacemente attaccate al desiderio di vivere. Clemantine inizia il viaggio che ha sei anni, Claire è appena diventata adolescente.
Poi c'è la vita di Clemantine negli Stati Uniti, dove arriva quando tocca a lei, essere adolescente. E qui, dove finalmente non ha più il problema della sopravvivenza, Clemantine cerca di dare un senso alla sua esistenza, non riuscendo a trovarsi a proprio agio in quel ruolo che molti si aspettano lei assuma: quello della sopravvissuta, vittima di guerra che ringrazia la buona sorte e le persone di buon cuore che le hanno permesso di ricominciare tutto da capo. Certo, mostra gratitudine a chi le ha dato tanto, ma questo non le basta per rimettere insieme i pezzi della sua storia.
Emblematico è il racconto che fa di un momento in cui, a un convegno, un relatore racconta di come alcuni profughi che aveva incontrato avessero l'ansia di digitalizzare, così da non perderle, alcune foto che s'erano portate appresso. Al relatore sembra una cosa curiosa, quasi divertente: "non sai se riuscirai a mangiare e pensi alle foto?". Clemantine spiega che quelle foto, spesso, sono l'unica connessione con un passato che ti è stato sottratto in modo brutale.
«La ragazza che sorrideva perline» è uno dei libri più interessanti che abbia letto, intorno alla vicenda del genocidio del 1994. Perché da lì prende spunto per farci entrare nella condizione di persone che, a causa di violenze, sono costrette a vagare, in cerca prima di un modo per sopravvivere e poi di un modo per tenere insieme la propria coscienza.
In realtà il titolo è un po' fuorviante. Lo stesso autore spiega che la punizione, in effetti, a qualcosa serve. Serve a più cose, ma nessuna di questa ha qualcosa a che fare con l'educazione. Non parliamo solo delle punizioni corporali - che, va ricordato, sono sempre sul filo della legalità - ma di tutte le punizioni in generali.
Sono ancora diffuse, molto diffuse, eppure, dimostra bene Novara, non aiutano chi le riceve a fare un passo avanti nel percorso di crescita.
Ci sono molti spunti interessanti, in questo libro di Daniele Novara, suggerito a genitori ed educatori in generale.
Sono ancora diffuse, molto diffuse, eppure, dimostra bene Novara, non aiutano chi le riceve a fare un passo avanti nel percorso di crescita.
Ci sono molti spunti interessanti, in questo libro di Daniele Novara, suggerito a genitori ed educatori in generale.
Saper leggere i dati, saper vedere le cose. Factufulness racconta questo. Usando i dati più affidabili a disposizione (quelli ONU e Banca Mondiale, prevalentemente) Hans Rosling ci mostra come il mondo, su molti fronti, è in rapido miglioramento. Solo che non ce ne accorgiamo.
Dal punto di vista delle condizioni di vita delle persone, dell'uscita dalla povertà estrema, dell'istruzione, della parità di genere. Attenzione: non dice che al mondo va tutto bene, dice che, su molte questioni, le cose stanno migliorando e lo fanno a una velocità impressionante.
A migliorare in modo estremamente rapido sono le condizioni di vita in molti paesi asiatici e africani, e facciamo tenerezza, noi Europei - ma pure statunitensi - strenuamente impegnati nel difenderci da un mondo che, nel giro di qualche decennio, ci supererà di slancio.
(A proposito di andamenti, va detto che, dopo la pubblicazione di questo libro, sono usciti dati FAO che documentano una battuta d'arresto nella lotta alla fame nel mondo: una situazione drammatica, ovviamente, che però ancora non è un andamento. Occorre vedere cosa succede negli anni prossimi).
Sia chiaro: questo libro non dice che il mondo va bene e non bisogna preoccuparsi. Dice che dobbiamo imparare a riconoscere i veri grandi problemi che ci si parano davanti. E no, tra questi non rientra l'immigrazione. Rientrano invece il cambiamento climatico, la possibilità di una pandemia come quella del 1919, lo scoppio di un conflitto planetario.
'Curiosamente', i nostri leader di governo - penso agli Stati Uniti, all'Italia e altri paesi europei - sui problemi prioritari nicchiano, mentre su quelli che sarebbero gestibili senza particolari difficoltà, per potenze sviluppate come le nostre, montano su un cinematografo che lèvati. Ancora più 'curiosamente', noi cittadini gli andiamo dietro.
Dal punto di vista delle condizioni di vita delle persone, dell'uscita dalla povertà estrema, dell'istruzione, della parità di genere. Attenzione: non dice che al mondo va tutto bene, dice che, su molte questioni, le cose stanno migliorando e lo fanno a una velocità impressionante.
A migliorare in modo estremamente rapido sono le condizioni di vita in molti paesi asiatici e africani, e facciamo tenerezza, noi Europei - ma pure statunitensi - strenuamente impegnati nel difenderci da un mondo che, nel giro di qualche decennio, ci supererà di slancio.
(A proposito di andamenti, va detto che, dopo la pubblicazione di questo libro, sono usciti dati FAO che documentano una battuta d'arresto nella lotta alla fame nel mondo: una situazione drammatica, ovviamente, che però ancora non è un andamento. Occorre vedere cosa succede negli anni prossimi).
Sia chiaro: questo libro non dice che il mondo va bene e non bisogna preoccuparsi. Dice che dobbiamo imparare a riconoscere i veri grandi problemi che ci si parano davanti. E no, tra questi non rientra l'immigrazione. Rientrano invece il cambiamento climatico, la possibilità di una pandemia come quella del 1919, lo scoppio di un conflitto planetario.
'Curiosamente', i nostri leader di governo - penso agli Stati Uniti, all'Italia e altri paesi europei - sui problemi prioritari nicchiano, mentre su quelli che sarebbero gestibili senza particolari difficoltà, per potenze sviluppate come le nostre, montano su un cinematografo che lèvati. Ancora più 'curiosamente', noi cittadini gli andiamo dietro.